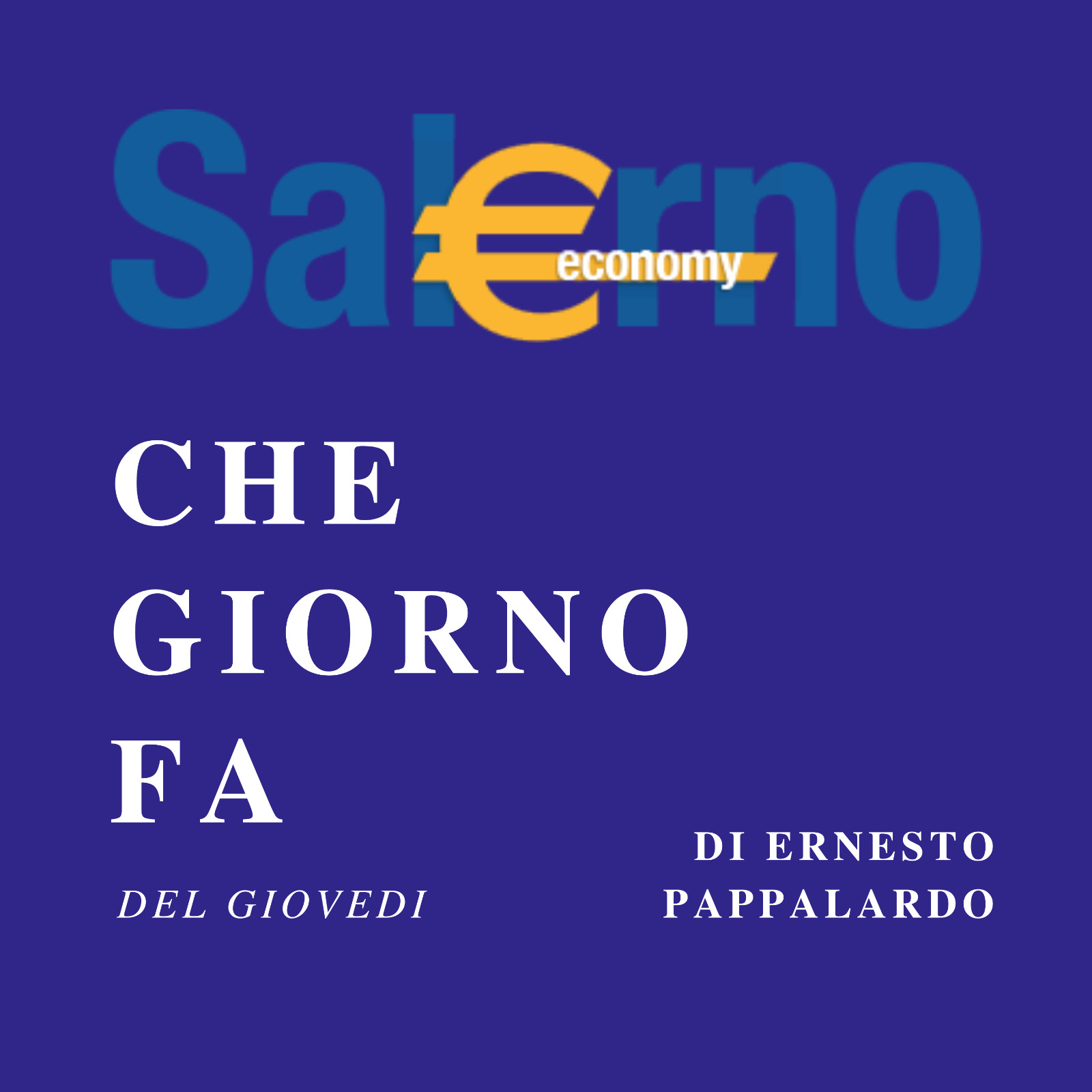La notizia del giorno »
L'altra notizia »
GLOCAL di Ernesto Pappalardo »

A proposito dei (quasi) 3.000 miliardi di debito pubblico
E’, ormai, evidente che i tremila miliardi di debito pubblico cominciano ad avere un peso specifico più insistente sulla reale operatività del sistema-Italia, oltre che sulla capacità realmente rappresentativa delle Istituzioni nel contesto internazionale. La domanda che con più insistenza circola in vari contesti, importanti e meno importanti, è sempre la stessa: ma come si fa a prendere in considerazione un Paese che ha accumulato 3.000 miliardi di debito e vuole pure rappresentarsi per quello che non è? Non è una potenza dell’economia, sicuramente, né della politica, a prescindere da quale schieramento comanda, né di tante altre cose. Ma ne siamo davvero convinti o camminiamo su un orizzonte ondivago, forse non del tutto radicato, o forse ancora fugace, aggrappato a quanto una stessa Europa non è capace di fare? Ecco, siamo in questa situazione specifica, eppure pensiamo ad altro, non riusciamo a costruire, con tutto quel che ne consegue fin da adesso (sia ben chiaro), niente che vale la pena di ricordare. Ma, però, non si sa bene come, andiamo avanti, continuando ad accollarci - non possiamo fare altro - un debito insostenibile, a tal punto che risulta “inefficace” a mettere in moto una macchina decente e sostenibile (ma come?) per venirne fuori. La manovra in itinere? Dalle banche si attendono 3-4 miliardi, come pure si prevedono tagli del 5% ai vari ministeri, e, poi, il cuneo, le varie aliquote, il rivedimento dell’Irpef, oltre che la revisione di varie tipologie di bonus.
Ma, è evidente, non è un viaggio in sintonia con quell’enorme stato gassoso che evocano i tremila miliardi che, pure, alla fine delineano la reale condizione in cui versa l’Italia, indebitati fino al collo ma privi della consapevolezza che prima o poi il problema si scaricherà sui noi soliti noti che dovremo pagarlo.
(continua)
Ma, è evidente, non è un viaggio in sintonia con quell’enorme stato gassoso che evocano i tremila miliardi che, pure, alla fine delineano la reale condizione in cui versa l’Italia, indebitati fino al collo ma privi della consapevolezza che prima o poi il problema si scaricherà sui noi soliti noti che dovremo pagarlo.
(continua)
I numeri dell'economia »

La manovra finanziaria del governo, vale 30 miliardi
La manovra finanziaria varata dal governo ammonta a circa 30 miliardi lordi. Tra le novità rientrano la carta per i “nuovi nati”, l’intervento di 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni per il comparto sanità. Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000 euro, l’assegno unico fuori dal calcolo dell’Isee. Cambiano anche le detrazioni, con un primo “quoziente familiare”. Ed è prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. Programmati i tagli a i ministeri (5%).
“Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini”, ha sottolineato la premier, Giorgia Meloni. “3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni - ha specificato - sono destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”.
Tra le novità, quindi, spunta la carta dei nuovi nati per i genitori con Isee fino a 40mila euro, inoltre le famiglie più numerose avranno più spazi per le detrazioni fiscali. Vengono confermati gli incentivi al lavoro per giovani e donne nel Mezzogiorno, così come le misure dello scorso anno sulle pensioni, resta la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività, i fringe benefit sono confermati con importi maggiorati per i nuovi assunti che si trasferiscono oltre 100 km, la carta “dedicata a te” è rifinanziata con 500 milioni, si potenziano gli investimenti nella Difesa. E risultano incrementate le risorse per la Sanità.
Arriva a sorpresa e con una settimana d’anticipo rispetto al previsto la terza manovra del governo Meloni.
Il taglio del cuneo e Irpef a tre aliquote diventano strutturali. Interventi che, è stato assicurato dal presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato (FdI), permetteranno di abbassare la pressione fiscale dal 42,3% del 2024 al 42,1% nel 2025, riducendo così il dato tendenziale del 42,8% indicato nel Piano strutturale di bilancio. I tagli lineari saranno gestibili in modo flessibile: i singoli dicasteri decideranno come distribuire la cifra imposta dal Mef.
(continua)
“Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini”, ha sottolineato la premier, Giorgia Meloni. “3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni - ha specificato - sono destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”.
Tra le novità, quindi, spunta la carta dei nuovi nati per i genitori con Isee fino a 40mila euro, inoltre le famiglie più numerose avranno più spazi per le detrazioni fiscali. Vengono confermati gli incentivi al lavoro per giovani e donne nel Mezzogiorno, così come le misure dello scorso anno sulle pensioni, resta la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività, i fringe benefit sono confermati con importi maggiorati per i nuovi assunti che si trasferiscono oltre 100 km, la carta “dedicata a te” è rifinanziata con 500 milioni, si potenziano gli investimenti nella Difesa. E risultano incrementate le risorse per la Sanità.
Arriva a sorpresa e con una settimana d’anticipo rispetto al previsto la terza manovra del governo Meloni.
Il taglio del cuneo e Irpef a tre aliquote diventano strutturali. Interventi che, è stato assicurato dal presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato (FdI), permetteranno di abbassare la pressione fiscale dal 42,3% del 2024 al 42,1% nel 2025, riducendo così il dato tendenziale del 42,8% indicato nel Piano strutturale di bilancio. I tagli lineari saranno gestibili in modo flessibile: i singoli dicasteri decideranno come distribuire la cifra imposta dal Mef.
(continua)
Lo speciale »

E a Grumento la biblioteca diventa città
di Pasquale Persico
Nelle diverse sperimentazioni su come attrarre viaggiatori relazionali si deve segnalare l’opportunità di poter abitare biblioteche, spesso di rara bellezza e densità storica, per un periodo consistente, bastevole per produrre intrecci culturali inattesi. Incrociare storie e storia è proprio la caratteristica dello scrittore Alessandro Bresolin e lo rivela il libro Sofferente e fumatore. Camus, la bilancia di Giobbe, edito da Castelvecchi, nella tarda primavera del 2024. Di origini venete, napoletano e francese d’adozione, egli è autore di romanzi e saggi, è un traduttore dal francese, ha realizzato documentari radiofonici in Italia e all’estero e ha collaborato con Rai Radio 3. Incuriosito dal Progetto di DNA Maratea, che riporta in Val d’Agri, al Museo Archeologico, con l’esperienza artistica di Mimmo Longobardi, la mostra antologia Ancor Camus, Alessandro Bresolin chiede al Comune di Grumento di diventare cittadino residente equivalente. Egli sceglie, per tale ipotesi, la figura di aiuto bibliotecario temporaneo, nell’intento di aprire un dialogo profondo sugli intrecci tra patrimonio della biblioteca e paesaggi incrociati dell’area vasta in Val D’Agri. Sfidare le fonti storiche e le storie chiuse nelle case delle comunità della valle, significa navigare nelle fonti storiche, quelle filosofiche, le letterarie, le aneddotiche, quelle religiose e biografiche, con il potenziale risultato di un’esperienza corale ed inedita fatta di incontri, per attrarre nuovi visitatori della Biblioteca e del luogo in generale.
(continua)
Nelle diverse sperimentazioni su come attrarre viaggiatori relazionali si deve segnalare l’opportunità di poter abitare biblioteche, spesso di rara bellezza e densità storica, per un periodo consistente, bastevole per produrre intrecci culturali inattesi. Incrociare storie e storia è proprio la caratteristica dello scrittore Alessandro Bresolin e lo rivela il libro Sofferente e fumatore. Camus, la bilancia di Giobbe, edito da Castelvecchi, nella tarda primavera del 2024. Di origini venete, napoletano e francese d’adozione, egli è autore di romanzi e saggi, è un traduttore dal francese, ha realizzato documentari radiofonici in Italia e all’estero e ha collaborato con Rai Radio 3. Incuriosito dal Progetto di DNA Maratea, che riporta in Val d’Agri, al Museo Archeologico, con l’esperienza artistica di Mimmo Longobardi, la mostra antologia Ancor Camus, Alessandro Bresolin chiede al Comune di Grumento di diventare cittadino residente equivalente. Egli sceglie, per tale ipotesi, la figura di aiuto bibliotecario temporaneo, nell’intento di aprire un dialogo profondo sugli intrecci tra patrimonio della biblioteca e paesaggi incrociati dell’area vasta in Val D’Agri. Sfidare le fonti storiche e le storie chiuse nelle case delle comunità della valle, significa navigare nelle fonti storiche, quelle filosofiche, le letterarie, le aneddotiche, quelle religiose e biografiche, con il potenziale risultato di un’esperienza corale ed inedita fatta di incontri, per attrarre nuovi visitatori della Biblioteca e del luogo in generale.
(continua)